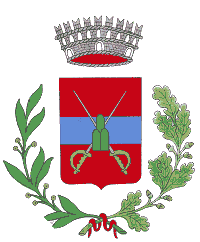
SERNAGLIA
DELLA BATTAGLIA
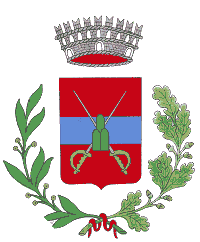
Sernaglia.
I primi insediamenti risalgono al paleolitico medio sui terrazzi lungo il corso
del Piave in località Fornace, Ca'Mira e Molini a Falzé, dove esistevano
centri di lavorazione della selce. In zona Castelich a Sernaglia sono state
rinvenute tracce di accampamenti fortificati (Castellieri). Testimoniata anche
la presenza paleoveneta nell'area del Pedrè a Falzé, così come la
penetrazione romana con la via Claudia Augusta Altinate: esiste ancora un ponte
nei pressi di Villa Jacur e tombe sono venute alla luce in vari luoghi.
In un documento dell'età longobarda, datato 762, sono registrate le doglianze
di prete Oddo, rettore di S. Maria di Sernaja, che difende i beni donati alla
Chiesa secondo una "pronuncia" del duca Orso, dalle pretese degli
eredi. Tale fatto ci porta a pensare che il paese esistesse, come nucleo di una
certa importanza, già parecchi anni prima.
Nel medioevo il territorio appartenne ai vescovi di Belluno e poi di Ceneda; fu
concesso come feudo alla famiglia dei Della Rovere, che edificarono un castello,
poi distrutto nel 1234 da Ezzelino da Romano. Sernaglia è citata come pieve già
nel 1122. Dal XIV sec. divenne dominio dei Collalto, sotto il controllo della
Serenissima. In epoca recente divenne fronte nemico durante la Grande Guerra:
distruzioni e crisi economica produssero un pronunciato fenomeno di emigrazione.
Sulle origini del nome si è
equivocato sino a poco tempo fa. Lo si voleva far risalire a "seracanaja"
in quanto nel Castelich, in località Prà de Tomba, pare esistesse una prigione
in cui i condannati, in preda a fabbri malariche, languivano e perivano. Sebbene
l'archivio parrocchiale sia andato distrutto completamente nel corso della
Grande Guerra, non si può affermare che il tutto sia frutto della sola
immaginazione. Un manufatto, all'interno della palude, il solo della zona,
doveva sorgere nel Prà de Tomba. Alcune pietre e un terrapieno, la cui
struttura geometrica evidenziava la mano dell'uomo, lo dimostravano. E' logico,
invece, dedurre che il nome derivi dalla potente famiglia dei Sernaja che
signoreggiò nel luogo fin dall'epoca longobarda.
Perché della Battaglia? Dopo la rotta di Caporetto, ottobre 1917, la piana
della Sernaglia è venuta a trovarsi in prima linea. Gli abitanti dovettero
cercare rifugio nei paesi oltre le colline, nel vittoriese e nel Friuli. Per
vecchi e bambini (gli uomini erano a combattere al di là del Piave) ebbe inizio
un anno di stenti e privazioni. Il tributo di Sernaglia è stato di una persona
ogni nove residente allora in paese. Ad eccezione della ciminiera della filanda,
tutto il paese andò distrutto sotto i colpi delle artiglierie italiane del
Montello, che si accanirono particolarmente contro l'alto campanile, costruito
nel 1620 su disegno del Sansovino, la cui cella campanaria era stata tramutata
in osservatorio dal quale gli Austriaci potevano controllare l'intera dorsale
nord del Montello. Oltre 200 bocche da fuoco di ogni calibro appoggiarono
l'attacco delle nostre truppe che attraversavano il fiume su ponti di barche,
tempestando letteralmente le forze nemiche che tentavano di ricacciarle di là
del Piave. Il 29 ottobre la Battaglia della Sernaglia era vinta, la via di
Vittorio Veneto era aperta.
Lapidi e monumenti ricordano quei giorni gloriosi e terribili. Oltre a quello
dei combattenti, uno, l'unico in Italia, è dedicato agli Arditi. Il terzo al
XXX Fanteria, la cui bandiera è stata insignita di medaglia d'oro per l'eroico
comportamento dei suoi fanti che a Sernaglia respinsero l'ultimo violento
contrattacco dei reparti scelti austriaci.
Da
vedere:
Le grave del fiume Piave, le risorgive(Acque Bianche) e i Palù.
L'Isola dei Morti é un comprensorio boschivo steppico-arbore-arbustico tipico
delle grave del Piave e di macchie ordinate di Pioppo nero, Ginepro, Salice,
Corniolo e Biancospino.
Vie intitolate ai reggimenti che qui combatterono nella battaglia del Piave del
1918 confluiscono ad una piazzale con monumento, cappella e cimeli della guerra;
una via porta al Piave, dove si possono studiare i ciottoli, i limi e le
erosioni del fiume sacro alla patria.
Chiesa parrocchiale (1922) dedicata a Santa Maria Assunta con il suo slanciato campanile, il cui disegno è stato attribuito al
Sansovino (1640) con le due colonne poste all'ingresso del sagrato, ricordo
della precedente chiesa cinquecentesca, distrutta dalla Grande Guerra.
Parrocchiale di San Nicola di Fontigo, con la sua semplice ed elegante facciata:
Parrocchiale di San Martino a Falzé.
Monumento all'Emigrante (la pietra custodisce un' urna in cui è stata
raccolta la terra inviata dagli emigranti di sedici nazioni di tutti e cinque i
continenti) di Eugenio Villanova.
Fontana con Titano che scaccia le aquile asburgiche, opera di Giovanni Possamai
in piazza san Rocco.
I Tre Arditi dello stesso scultore nella piazza principale di Falzé.
Chiesuola a Falzé: la Madonna con Bambino che sovrasta l'altare, è attribuita
al pittore Giovanni di Francia (XV sec,); l'affresco della parete di destra
(Madonna con Bambino tra Santi) è datato 1515.
Personaggi illustri:
Villanova Venanzio (1916-88) fu un salesiano che operò in India, dove perì
in un incidente stradale, dopo aver creato strutture per i poveri e dispensari
per i lebbrosi.
Giambattista Gobbato divenne vescovo in Birmania, dove aprì pure un
lebbrosario.
Pillonetto Giocondo (1910-81) fu invece oste e poeta: la sua Penultima fiaba
apparve postuma.
Villanova Eugenio (1921-79) lavorò il ferro battuto: suo il celebre monumento
dedicato all'Emigrante.
Anche il pittore e scultore Lorenzon Angelo (1927-78) è sernagliese.

|
|
 Chiesa parrocchiale
|

|

|
|
|
|
|
|
|
|