Personaggi

Personaggi |
 |
DON CARLO GNOCCHI |
 |
Don CARLO GNOCCHITerzogenito di Enrico Gnocchi, marmista, e Clementina Pasta, sarta,
|

|
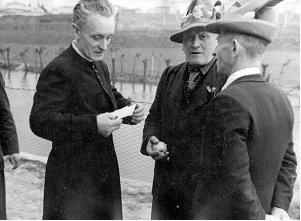 Rimasto orfano del padre all'età di cinque anni, si trasferisce
a Milano con la madre e i due fratelli, Mario e Andrea, che di lì a poco
moriranno di tubercolosi.
Rimasto orfano del padre all'età di cinque anni, si trasferisce
a Milano con la madre e i due fratelli, Mario e Andrea, che di lì a poco
moriranno di tubercolosi.
Seminarista alla scuola del Cardinale Andrea Ferrari,
nel 1925 viene ordinato sacerdote dall'Arcivescovo di Milano Eugenio Tosi.
Celebrerà la sua
prima Messa il 6 giugno a Montesiro, paesino della Brianza.
Il primo impegno apostolico del giovane don
Carlo è quello di assistente dell'oratorio: prima a Cernusco sul
Naviglio, poi, dopo solo un anno, nella popolosa Parrocchia di San Pietro in
Sala, a Milano. Raccoglie stima e consensi dalla gente tanto che la fama delle
sue doti di ottimo educatore giunge fino in Arcivescovado; nel 1936, infatti,
il Cardinale Ildefonso Schuster lo nomina direttore spirituale di una delle
scuole più prestigiose di Milano: l'Istituto Gonzaga dei Fratelli delle
Scuole Cristiane. In questo periodo studia intensamente e scrive brevi saggi
di pedagogia.
Sul finire degli anni trenta, il
Cardinale Schuster gli affida l'incarico dell'assistenza spirituale degli
universitari della Seconda Legione di Milano, comprendente in buona parte
studenti dell'Università Cattolica e molti ex allievi del Gonzaga.
|
|
La Guerra
Nel
1940 l'Italia entra in guerra e molti giovani studenti vengono chiamati al
fronte. Don Carlo, coerente alla tensione educativa che lo vuole sempre
presente con i suoi giovani anche nel pericolo, si arruola come cappellano
volontario nel battaglione "Val Tagliamento" degli alpini, con destinazione
il fronte greco albanese.
La campagna di Russia
Terminata la campagna nei Balcani, dopo un breve intervallo a Milano, nel 1942
riparte per il fronte, questa volta in Russia con gli alpini della
Tridentina.
Nel gennaio del 1943 inizia la tragedia della ritirata del contingente
italiano: don Carlo, caduto stremato ai margini della pista dove passava la
fiumana dei soldati, viene miracolosamente raccolto su di una slitta e
salvato. E' proprio in questo frangente che, assistendo gli alpini feriti e
morenti, raccogliendone le ultime volontà, matura in lui l'idea di realizzare
una grande opera di carità che troverà compimento, dopo la guerra, nella
Fondazione Pro Juventute.
Ritornato in Italia nel 1943, don Carlo inizia il suo pietoso pellegrinaggio,
attraverso le vallate alpine, alla ricerca dei familiari dei caduti per dare
loro un conforto morale e materiale.
In questo stesso periodo aiuta molti partigiani e politici a fuggire in
Svizzera, rischiando in prima persona vita; lui stesso viene arrestato dalle
SS con la grave accusa di spionaggio e di attività contro il regime.
 Gli orfani e i mutilatini
Gli orfani e i mutilatini
A partire dal 1945 comincia a prendere forma concreta quel progetto di aiuto
ai sofferenti appena abbozzato negli anni della guerra: viene nominato
direttore dell'Istituto Grandi Invalidi di Arosio e accoglie i primi orfani di
guerra e i bambini mutilati. Inizia così l'opera che lo porterà a guadagnare
sul campo il titolo più meritorio di "Padre dei mutilatini".
Ben presto la struttura di Arosio si rivelerà insufficiente ad accogliere i
piccoli ospiti le cui richieste di ammissione arrivano da tutta Italia; ma,
quando la necessità si fa impellente, ecco intervenire la Provvidenza.
Nel
1947, gli viene concessa in affitto, a una cifra simbolica, una grande casa a
Cassano Magnago nel varesotto.
Nel 1949 l'Opera di
don Gnocchi ottiene un primo riconoscimento ufficiale: la "Federazione
Pro Infanzia Mutilata", da lui fondata l'anno prima per meglio coordinare
gli interventi assistenziali nei confronti delle piccole vittime della guerra,
viene riconosciuta ufficialmente con Decreto del Presidente della Repubblica.
Nello stesso anno, Alcide De Gasperi, capo del governo, promuove don Carlo
consulente della Presidenza del Consiglio per il problema dei mutilatini di
guerra. Da questo momento uno dopo l'altro, aprono nuovi collegi: Parma
(1949), Pessano (1949), Torino (1950), Inverigo (1950), Roma (1950), Salerno
(1950), Pozzolatico (1951).
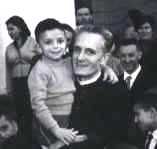 Nel 1951 la Federazione Pro Infanzia Mutilata viene sciolta e tutti i beni e
le attività vengono attribuiti al nuovo soggetto giuridico creato da don
Gnocchi: la Fondazione Pro
Juventute, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica l'11
febbraio 1952.
Nel 1951 la Federazione Pro Infanzia Mutilata viene sciolta e tutti i beni e
le attività vengono attribuiti al nuovo soggetto giuridico creato da don
Gnocchi: la Fondazione Pro
Juventute, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica l'11
febbraio 1952.
Nel 1955 don Carlo lancia la sua ultima grande sfida: si tratta di costruire
un moderno Centro che costituisca la sintesi della sua metodologia
riabilitativa. Nel settembre dello stesso anno, alla presenza del Capo dello
Stato Giovanni Gronchi, viene posata la prima pietra della nuova struttura,
nei pressi dello stadio San Siro, a Milano.
A don Carlo, ormai minato da una malattia incurabile, non
sarà dato di vedere il completamento dell'opera nella quale aveva investito
le maggiori energie
 L’addio a un "santo"
L’addio a un "santo"
Il 28 febbraio 1956, la morte lo raggiungerà
prematuramente presso la Columbus, una clinica di Milano dove era da tempo
ricoverato per una grave forma di tumore..
«Era sotto la tenda a ossigeno – ricorda don Giovanni
Barbareschi, amico fedele ed esecutore testamentario -.
Parlava solo ogni
tanto e solo a me.
La mattina alle sei chiese il piccolo crocifisso che la
mamma gli aveva regalato per la Prima Messa e volle che fosse appeso sulla
tenda per vederlo sempre.
Lo appendemmo con del nastro adesivo. Don Carlo
lo guardava e gli parlava con gli occhi.
L’ultima parola che disse fu:
“Grazie di tutto…”. Verso sera si aggravò. Improvvisamente si appoggiò con
i pugni al materasso; prese, strappando l’adesivo, il crocifisso, lo
appoggio alle labbra, lo baciò e così
morì».
I funerali furono grandiosi per partecipazione e commozione: quattro alpini a sorreggere la bara, altri a portare
sulle spalle i piccoli mutilatini in lacrime.
 Poi la commozione degli
amici e conoscenti, centomila persone a gremire il Duomo e la piazza
e l’intera città di Milano listata a lutto. a tributargli onore e affetto,
saracinesche abbassate e chiese listate a lutto.
Poi la commozione degli
amici e conoscenti, centomila persone a gremire il Duomo e la piazza
e l’intera città di Milano listata a lutto. a tributargli onore e affetto,
saracinesche abbassate e chiese listate a lutto.
Così il 1° marzo ’56
l’arcivescovo Montini - poi Papa Paolo VI - celebrava i funerali di don
Carlo Gnocchi, l’indimenticato cappellano della Tridentina nella
disastrosa campagna di Russia e fondatore a guerra finita della “Pro
Juventute”, l’opera che coordinò gli interventi assistenziali a favore
delle vittime innocenti del conflitto e che gli valse il titolo
meritorio di “papà dei mutilatini”.
Tutti i
testimoni ricordano che correva per la cattedrale una specie di parola d’ordine:
“Era un santo, è morto un santo”.
«Durante il rito – ricorda Barbareschi – Montini mi disse: “Io non parlo, fai parlare un bambino”.
Fu preso
un bambino e portato al microfono disse: “Prima ti dicevo: ciao don Carlo.
Adesso ti dico: ciao, san Carlo”. Ci fu un’ovazione».
L’ultimo dono
L’ultimo dono
di Don Carlo ai mutilatini e al mondo fu la donazione delle cornee. Il
magistero della Chiesa non aveva ancora espresso un parere definitivo
sulla questione della donazione degli organi e il nostro Paese ancora non
si era dato una legge in materia. Ci pensò don Gnocchi a spingere
l’una e l’altro. «Lo disse già un anno prima: “Se dovessi
morire, voglio che cerchiate di dare i miei occhi a due dei miei
ragazzi. Mi restano solo gli occhi: anche questi sono per i miei
mutilatini”».
Era il 1956, i trapianti, ai tempi erano vietati. Ma lui volle lo
stesso far dono dei suoi occhi a due ragazzi. Don Carlo
Gnocchi era stato categorico con gli amici. «Tra poco non ci
sarò più. Donate i miei occhi a queste due persone. I nomi li conoscete. Ne
hanno più bisogno di me». Sapeva di avere un cancro incurabile. L'ultimo pensiero andò
ancora ai piccoli
con handicap fisici e mentali. Disse solo: «Amis, ve racumandi la mia
baracca».
Le ore che seguirono la morte di
don Gnocchi furono scandite dal dolore di un’intera città ma soprattutto dalla
concitazione degli amici. I più stretti si ricordavano di quella promessa che il
prete aveva strappato loro quasi con violenza. Ma le cose
non erano così semplici: il trapianto era vietato dalla legge
«Quasi sgomento - si legge
nel diario del professor Cesare Galeazzi, che con lui aveva studiato
al Gonzaga - pensavo alla prova che mi aspettava. Come
un principiante andavo ripetendomi i tempi dell’intervento... Poi a
tratti mi rasserenavo e mi dicevo: don Carlo mi aiuterà.
La notizia
era ormai su tutti i giornali. Il mio aiuto Celotti, recatosi alla
Columbus, fu intercettato dalla polizia: «Qui non si tocca niente». Non si
fece intimorire: aggirò la posizione e compì il suo triste compito di
asportare i bulbi oculari di don Gnocchi.
All’uscita
dalla clinica la sua auto fu per un tratto seguita da quella della
polizia. Che poi fece volutamente finta di perderla».
Furono scelti Silvio Colagrande e
Amabile Battistello che vennero subito avvisati di
tenersi pronti ad entrare in sala operatoria.
Allora non c’era il
laser. L’anestesia durò dalla mattina
fino a sera fonda. Poi venne un periodo di assoluta immobilità: venti giorni a
letto, una benda calata sugli occhi e un sacco di sabbia appoggiato dietro il
collo. Il peggio furono i
punti, che si riassorbirono molto lentamente. Ma la vista andò a posto.
vedi anche 1996 In corso la causa di beatificazione